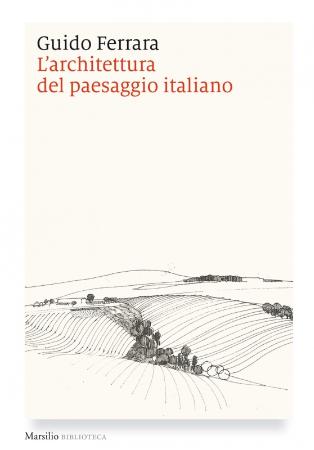Editoria, "L'architettura del paesaggio italiano"
Marsilio riedita lo storico saggio di Guido Ferrara
Roma, 22 marzo 2017 - L’architettura del paesaggio italiano, Guido Ferrara, Marsilio. Che il nostro sia chiamato Bel Paese non è certo una novità, anzi, l’espressione è diventata qualcosa di molto simile a un epiteto retorico, a una frase formulare come quelle che usavano gli antichi aedi e i rapsodi per non perdere il filo o lasciare spazi vuoti quando cantavano in metrica le storie di Achille, Ettore, Andromaca, Paride, Ulisse e gli altri: la gran parte del patrimonio artistico mondiale si staglia tra l’Alto Adige e la Sicilia, tra il profondo nordovest e l’estremo sudest dello Stivale. È la principale materia prima che possediamo, visto che certo non possiamo contare su oro, argento, diamanti o petrolio: la bellezza. Che è per antonomasia immateriale, eppure le sue ricadute sulla vita di tutti noi sono concrete, immediate, oggettive.
Ognuno aspira al bello, sceglie ciò che in base ai suoi gusti più gradisce perché lo fa stare bene. E chi sta bene lavora bene, vive bene, si rende meglio utile per la società. Inoltre i concetti di bellezza e patrimonio artistico in Italia sono collegati a un altro tema, per la cui salvaguardia si impegnano quotidianamente e da decenni numerose associazioni, perché appartiene a tutti, e se è di tutti è bene che tutti ne abbiano cura, per non avere poi in futuro di che lamentarsi e pentirsi, per non dover rimpiangere quel che un tempo c’era, per non doversi giustificare con i figli da cui hanno preso in prestito il mondo riconsegnandoglielo più inquinato e violentato dalla speculazione selvaggia che, tra l’altro, è tutto fuorché rispettosa delle norma canoniche dell’estetica, visto che produce ecomostri su ecomostri, oltre a foraggiare spesso a vario titolo l’illegalità: il paesaggio. Ossia il nostro ambiente, il luogo nel quale siamo vissuti e attraverso il quale veniamo in contatto con il mondo, traendone esperienza, il contesto che ci definisce e che delinea le caratteristiche fondamentali del nostro immaginario collettivo, che si evolve col tempo. Non semplice sfondo, ma personaggio di primo piano nella trama del nostro vivere: la Gioconda sarebbe tutt’altra se alle sue spalle svettassero i grattacieli di Manhattan, è ovvio. Il paesaggio è fatto di mari, monti, fiumi, coste, boschi, rive, colline. Ma anche di ponti, strade, palazzi, città. Ossia di natura e intervento umano, che devono amalgamarsi con armonia, altrimenti gli esiti potrebbero essere nefasti. E non solo da un punto di vista meramente estetico: spesso infatti quando si viola la bellezza si dissesta letteralmente il territorio. E ormai nel 2017 è difficile credere che ci sia ancora chi, almeno in teoria più che qualificato per avere piena contezza dei fenomeni che gli capitano sotto agli occhi, voglia far credere di non essere stato in grado di aspettarsi, per esempio, che un terreno privato di tutti gli alberi potesse franare, o che un fiume incastrato nel cemento non trovasse alla fine uno sbocco per il suo fluire. D’altro canto le infrastrutture sono indispensabili per la nostra vita: devono essere fatte. Bene, però, e ben mantenute.
Guido Ferrara, già ordinario di Urbanistica e di Architettura del paesaggio a Firenze, fondatore e coordinatore del Master in Paesaggistica del medesimo ateneo, consulente per enti di governo del territorio, curatore di raccolte e libri fra cui La casa colonica in Toscana (1966), Risorse del territorio e politica di piano (1978), Landscape planning (1978), Parchi naturali e cultura dell’uomo (1994), Paradise on Earth. The gardens of the XXI Century (1996), La Carta di Napoli (1999) e Il paesaggio nella pianificazione territoriale (2012), parla con passione, competenza, spiccata attitudine divulgativa, linguaggio, punteggiato da splendide immagini, semplice e chiaro, precisissimo e più che documentato, anche attraverso un apparato di note e bibliografico formidabile, di tutto questo e di molto altro nel libro in oggetto, L’architettura del paesaggio italiano (e l’architettura del paesaggio è del resto una vera e propria disciplina, oltre che una professione), di cui a praticamente mezzo secolo di distanza – ma l’attualità delle tesi esposte è sorprendente – dalla prima comparsa sugli scaffali delle librerie esce una nuova edizione, corretta e rinnovata, che analizza il tema in senso geografico, storico, sociale, economico, politico, progettistico e progettuale, estetico, psicologico, conservativo, fornendo una miriade di dati e un incredibile patrimonio di spunti di riflessione e consapevolezza.
Un estratto del testo, che dimostra la sua incredibile attualità: “Un altro aspetto a carattere insediativo è quello che riguarda le strade. Il trasporto oggi è fondamentalmente basato sul mezzo individuale, più a causa della crescente spinta al consumo provocata dall’attuale fase della società che dalle reali necessità di trasporto. La circolazione sulle strade, di qualunque ordine e tipo, si infittisce fino a diventare caotica, e i problemi del traffico propongono continuamente e con urgenza di rinnovare la rete viaria, perché quella esistente non è più capace di reggere la spinta attuale sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Le necessità di reperire spazio per il traffico motorizzato privato si fa sentire ogni giorno più forte, perché alle notevoli capacità di deflusso delle nuove grandi arterie autostradali si devono unire i problemi derivanti dalla velocità delle auto: per motivi di sicurezza ciò porta a sezioni stradali di una larghezza del tutto inusitata rispetto al passato e quindi con problemi inediti di rapporto con il paesaggio. Le aree occorrenti per il traffico non sono soltanto quelle relative alla viabilità grande e piccola, ma anche quelle necessarie per le attrezzature di parcheggio, che assumono proporzioni veramente allarmanti nei centri abitati e nelle zone di loro pertinenza. I problemi relativi alla costruzione delle grandi autostrade non sono legati soltanto agli aspetti quantitativi di occupazione dello spazio ma anche a quelli relativi alle laboriose operazioni occorrenti per costruirle, dagli scavi in trincea che tagliano in due le colline, ai grandi riporti di terreno nelle zone di pianura, all’apertura delle cave di prestito che comportano sempre manomissioni al paesaggio. Tutto ciò non fa che approfondire la grande differenza concettuale di base esistente fra le nuove strade e il territorio, dato che esse scompaginano la sua architettura, ne ignorano la problematica formale e vi introducono elementi del tutto eterogenei. Se è possibile attribuire i contrasti più violenti fra il vecchio e il nuovo nelle città all’intervento delle forze speculatrici sulle aree fabbricabili, ciò non è generalmente più lecito nel caso delle strade, ma, nonostante ciò, nulla impedisce egualmente che boschi e piantagioni vengano tagliati, che montagne e colline siano sventrate, che la pubblicità delle aree di servizio si ponga in stridente contrasto con l’ambiente. Anche in questo caso, come è facile immaginare, si verificano squilibri di varia natura nell’ambiente, poiché di norma la strada frammenta per un vasto tratto la continuità naturale dei luoghi, a meno che il problema non sia stato affrontato fin dall’inizio della fase progettuale. La meccanizzazione individuale, d’altro canto, comporta anche altri modi di intervento negativo sul paesaggio. Le vie di comunicazione esistenti sono continuamente soggette a modificazioni e il loro percorso viene rettificato sia dal punto di vista altimetrico che planimetrico, mentre tracciati minori vengono aperti sia per determinati raccordi, sia per raggiungere luoghi finora poco accessibili. La presenza stessa del traffico motorizzato individuale, del resto, facilita a dismisura le possibilità di modificazione del paesaggio, attraverso la continua immissione di un numero di persone rilevante entro gli spazi aperti, per quanto remoti essi siano, tanto che se si facesse un’indagine rigorosa su quale sia lo «sport» più praticato a livello popolare, risulterebbe certamente che è quello di viaggiare in auto o in moto per diporto”.
L’architettura del paesaggio italiano, Guido Ferrara, Marsilio (pp. 226-7)