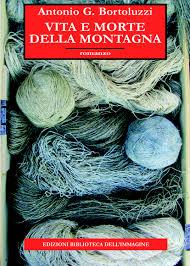Editoria, "Vita e morte della montagna" di Antonio G. Bortoluzzi
Dall'abbandono delle montagne negli anni Sessanta alla crisi economica, un ritratto della provincia veneta negli ultimi cinquant'anni
Roma, 18 novembre 2013 - Le storie per essere straordinarie molto spesso non devono possedere grandi elementi narrativi, troppi colpi di scena, ma semplicemente raccontare il lento, doloroso fardello della vita. Il malinconico succedersi degli eventi, il cambiamento, storico e sociale, che porta al pensiero di un “come eravamo” silenzioso, sincero e pensante. Giacomo Casàl è un operaio specializzato del bellunese che ha appena ricevuto una lettera di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. La crisi colpisce tutti e il mondo non è più quello florido del nord-est in espansione nel quale Giacomo è cresciuto. Gli anni in cui nella speranza di un successo industriale e a seguito di una serie di disastri ambientali, tra i quali il crollo della diga del Vajont, le popolazioni montanare erano state costrette a trasferirsi a valle lontano da quelle vette nelle quali erano nati e cresciuti e dove i propri avi avevano messo radici. Il rifiuto di quel passato nelle nuove generazioni, che avevano preso il toro per le corna e si erano impossessati con spirito imprenditoriale della propria vita e del proprio futuro. È questa la vita di Giacomo, orgoglioso delle sue abilità manuali di operaio e cresciuto all’ombra del mito industriale degli anni Sessanta e Settanta, che lo ha portato ad abbandonare la montagna e tutto il suo retaggio. A rifiutarla, perché il lavoro della terra era inutile, non valeva lo sforzo. E oggi che anche il mito dell’industrializzazione è morto, la vita sembra ancora più malinconica, impalpabile, indefinibile. Così, Giacomo ormai uomo di mezz’età torna su quella montagna a pensare al suo passato e a fare i conti con se stesso. A fare i conti con quello che è rimasto di noi.
Raramente negli ultimi anni si possono leggere romanzi dalla semplicità disarmante come questo Vita e morte della montagna dove il racconto diventa un’ode della vita, dell’essenza stessa dell’essere umano, dove la narrazione e i fatti sono ridotti all’osso e al tempo stesso sono così universali e potenti da toccare corde inesprimibili della propria interiorità. Spesso, i romanzi oggi sono costruiti con forza attraverso tecniche e formalismi impeccabili per portare il lettore alle emozioni, ma a conti fatti queste appaiono troppo artefatte, frutto del lavoro che è più quello di un buon editor che di un buon autore. Antonio G. Bortoluzzi invece lavora sul testo con una inaspettata potenza letteraria, dove il tono è quello monocorde della sottrazione che alla fine trasmette un senso inarrestabile di sentimenti contrastanti, che sono quelli del nostro tempo in relazione ad altri, più lontani e profondamente diversi, dove il vuoto intorno all’esistenza diventa sempre più incolmabile, profondo, lacerante. Bortoluzzi racconta gli anni della crescita che corrispondono all’infanzia e all’adolescenza di Giacomo che osserva con occhi incantati le prime canzoni sulla ribellione giovanile, i primi motorini, i primi amori, le prime esperienze sessuali, lo stile di vita di un mondo ormai scomparso che lasciava intendere che tutto sarebbe andato bene. Tutto sarebbe sempre andato in avanti, mai indietro. L’amarezza di Vita e morte della montagna consiste proprio nel prendere coscienza della verità. Un romanzo straziante narrato con tono bucolico dove si alternano montagna, campagna, natura ad asfalto, strade, catene di montaggio. Semplicità lirica, tragica, meravigliosamente perfetta, viva.
Antonio G. Bortoluzzi, Vita e morte della montagna, 144 pp.; Edizioni Biblioteca dell’immagine, 2013; 14,00 €