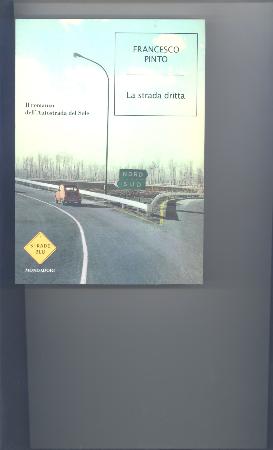Il romanzo dell'Autostrada del Sole
Intervista a Francesco Pinto, autore del libro "La strada dritta"
Un’opera di pubblica utilità che incarna lo Zeitgeist: il sentimento del tempo di un popolo. È la storia romanzata dell’Autostrada del Sole, la spina dorsale del paese. Per srotolare quel tappeto d’asfalto di settecentocinquantasei chilometri tra Milano e Napoli, ci sono voluti appena sette anni e dieci mesi. Siamo negli anni del boom economico. Altri anni, altre disponibilità economiche del paese, altro temperamento soprattutto. Così Francesco Pinto al suo primo romanzo, tratteggia la storia, o meglio, le storie eroiche dei personaggi (alcuni frutto della fantasia dello scrittore) che hanno realizzato l’Autostrada A1. Un genere ibrido quello scelto da Pinto, ex direttore di Rai 3, e attuale direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli, a metà strada fra il saggio e il romanzo. C’è la ricostruzione storica di un’epoca descritta con tratti epici, c’è l’indagine sociologica delle abitudini e dei consumi di un popolo che vuole emanciparsi, e le spiegazioni tecniche dei lavori nei tratti più difficili del tracciato. Il tutto tenuto assieme da una tessitura narrativa ben congegnata e da una scrittura asciutta.
Pinto, è vero che l’idea del romanzo sull’Autosole le è venuta osservando le travi che sostengono l’auditorium Rai di Napoli?
E’ proprio così. Stavamo preparando un libro sulla storia della rai di Napoli e un giovanissimo ingegnere di ottanta anni, Renato Sparacio, mi raccontò che le travi che lo tenevano sospeso erano in cemento precompresso.
“Sono le stesse travi utilizzate per il ponte sul Po dell’autostrada del sole” mi disse.
E così mi sono imbattuto in questa storia che, fin dalle prima ricerche, mi sembrò incredibile. Non avevo mai scritto una riga di narrativa e così provai ad offrirla ad un amico che purtroppo vedo pochissimo: Roberto Saviano. Lui mi rispose che chi ha tra le mani una storia ha il dovere di raccontarla.
Rimasi incerto fino a quando scoprii che, quando avevano inaugurato il primo cantiere, non c’era nemmeno il progetto definitivo. Allora mi feci coraggio pensando che se quel gruppo di uomini aveva iniziato un’impresa così grande con così pochi mezzi, forse potevo provare anche io. E iniziai.
Il progetto del tracciato su quella mappa, che «sembrava uno di quei giochi della “Settimana Enigmistica”: unite i punti per scoprire il disegno misterioso», si è tradotto in pochi anni in viadotti, gallerie, asfalto. Com’è stato possibile, in tempi ragionevoli, realizzare l’opera che ha davvero unito materialmente l’Italia?
Ci sono molte ragioni “materiali” (leggi più semplici, una situazione economica favorevole, meno Enti ecc ecc), ma io credo che alla fine la vera spiegazione sia nello “spirito del tempo”.
Quella era un’Italia che davvero voleva entrare in Europa dalla porta principale dimostrando al mondo che non era la nazione “vigliacca” uscita dalla guerra, ma un grande Paese con grandi sogni e grandi speranze.
Credo che qui sia il punto vero che era quasi necessario raccontare.
Il mio romanzo non ha nulla di “nostalgico” sulla leggerezza e felicità degli anni del boom, ma al contrario vuole raccontare un’Italia “pesante” fatta di acciaio e cemento dove gli uomini volevano fare le cose perché era “giusto”. Questo coraggio non possiamo dimenticarlo perché se perdiamo la sua memoria non saremo mai più in grado di ritrovarlo.
Quanto ha contato la forza del progetto e soprattutto la volontà ostinata del pool di tecnici riuniti attorno alla figura di Fedele Cova, direttore della Società Autostrade?
Il progetto non era un “semplice” progetto di ingegneria.
Era una cosa più complicata e “grandiosa”: era l’idea di unire il Paese. Questo era quello che avevano in testa quegli uomini. Potevano partire con una autostrada più semplice (nella legge Romita ce ne erano altre da fare) e invece partirono con quella più complicata; potevano chiamare tecnici stranieri per la sua progettazione e invece vollero tutti italiani per la sua costruzione perché quella era la strada degli italiani, e serviva al Paese.
A questo credevano ed erano quasi obbligati a farla.
Che peso ha avuto il coraggio di questi uomini, sostenuto da una pezzo importante di politica, per superare l’iniziale ritrosia dell’Anas nei confronti di un progetto così ambizioso per l’epoca?
Il coraggio è il vero progetto dell’autostrada, vale più dei soldi, delle tecnologie, delle soluzioni ingegneristiche e non è depositato solo in quella impresa impossibile.
Qui vorrei spezzare una lancia a favore dell’Anas: è vero che all’inizio non comprese il progetto dell’autostrada, ma quando si trovò a costruire sotto la sua diretta responsabilità la Salerno Reggio Calabria (parlo del tracciato originale ovviamente) con procedure di gara d’appalto molto più complesse di quelle utilizzate dalla Società Autostrade per la A1, e su di un terreno orograficamente più difficile, costruì più di 500 chilometri di strada dritta in dieci anni.
E, allora, la domanda, la vera domanda non è quando sarà finita, su quel tratto, la famigerata terza corsia, ma perché allora eravamo coraggiosi e oggi siamo “vili”?
Nell’anno in cui si celebrano i 150 anni dell’Unità d’Italia, anche simbolicamente l’A1 rappresenta uno dei segni più evidenti della continuità territoriale del paese, che cosa manca, secondo lei, per ritrovare la stessa forza di portare avanti progetti così grandi, magari coniugando utilità e bellezza?
Mancano i sogni.
Scheda libro:
Editore: Mondadori
Anno: 2011
Pagine: 324
Prezzo: 18.00 €