Ripensare la mobilità in modo intelligente e sano
"Mobilità sostenibile. Muoversi nel XXI secolo": dall'ipermobilità alla qualità della vita delle persone e dell'ambiente nel nuovo libro dello storico e studioso dei trasporti Stefano Maggi
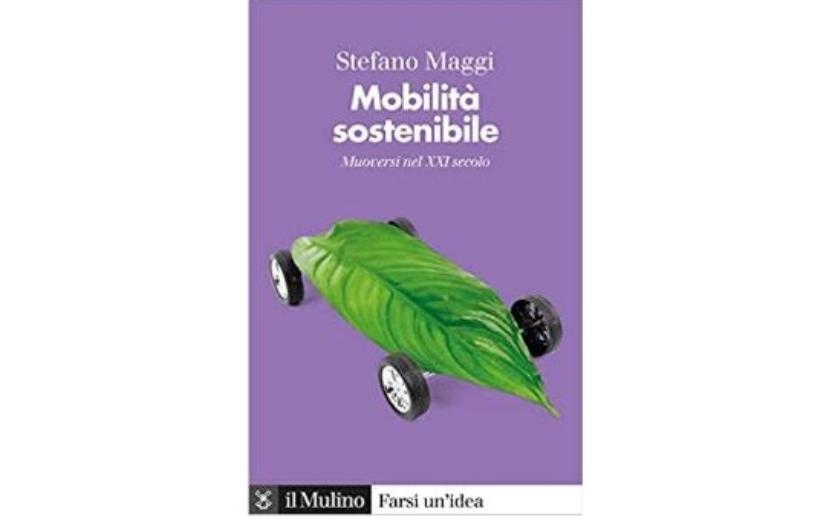
Gli autoveicoli (automobili, camion, autobus) in circolazione in Italia nel 1948 erano 415.272: a settant’anni di distanza sono più che centuplicati, raggiungendo la quota di 44,8 milioni nel 2018. Lo scrive Stefano Maggi nelle prime pagine del suo “Mobilità sostenibile. Muoversi nel XXI secolo” (recentemente pubblicato per Il Mulino). Da allora non solo l’Italia come Paese, ma pure il mondo intero, sono mutati proprio per il modo di concepire la mobilità, col tempo sempre più inquinante, e di conseguenza la quotidianità, gli affetti, i rapporti personali, il lavoro, tanto che Maggi nella sua attenta e approfondita analisi giunge a parlare di “ipermobilità”.
I veicoli motorizzati hanno invaso non solo le nostre strade, ma anche le nostre vite, determinando un’evoluzione radicale: come ricorda l’autore, i nostri nonni si spostavano molto meno, alcuni di loro non avevano la patente, si muovevano più che altro per il paese di residenza o nelle località limitrofe, a piedi o in bicicletta, ancor prima sui muli o nel migliore dei casi a cavallo. Noi invece in una giornata possiamo cambiare più volte regione o prendere per esempio un diretto Roma – Milano la mattina per rientrare la sera facendo il percorso inverso. Venendo meno così il limite fisico delle distanze attraverso il progresso dei trasporti la geografia delle città è stata ridefinita e ha portato all’enorme crescita dell’ultimo secolo.
In passato il treno, quando disporre di una carrozza definiva l’appartenenza sociale, ha condizionato significativamente per primo la mentalità del trasporto. Dall’Unità d’Italia in poi, una volta che il mezzo pubblico per eccellenza è entrato a far parte della cultura nazionale, viene incentivata la visione positiva del trasporto collettivo modificando la concezione individualistica degli italiani. Questa al contrario esploderà col boom economico, tanto che, se nel 1910 le automobili in Italia sono solo circa settemila, e nel 1911 la Fiat è soltanto al trentesimo posto fra le maggiori industrie italiane, salendo, però al terzo, dietro Ansaldo e Ilva, dopo la Grande Guerra, grazie alle commesse belliche, nel 1956 vengono immatricolate 126.099 Fiat 600 su una quantità complessiva di 201.771 autovetture.
È il progresso, il futuro che si proietta verso il benessere, pensando alla qualità della vita, ma sottovalutando uno degli elementi che più degli altri influisce su di essa, l’inquinamento, oggi alla base viceversa dell’idea di “sostenibilità”, concetto introdotto solamente nel corso degli anni Novanta del secolo scorso.
L’automobile, più di tutti gli altri mezzi, crea un cosiddetto “effetto sociale” analizzabile lungo i cambiamenti storici di tutto il Novecento. La popolazione cresciuta prima che l’automobile, in contemporanea con la televisione, divenisse un mezzo economico e popolare posseduto da tutti è diversa per censo, uso, conoscenza della lingua italiana e persino modo di vestire da quella cresciuta dopo. In parallelo cambiano i ruoli nella società per gli uomini e le donne e non di meno le abitudini di spostamento, nel bene e nel male, dato che l’uso massiccio dell’automobile aumenta l’inquinamento.
C’è infatti un rovescio della medaglia: la massificazione degli spostamenti da un luogo all’altro, per pendolarismo, turismo, tempo libero, ha creato continui incrementi del traffico di persone e merci.
Temi, a detta dell’autore, che hanno fatto nascere e crescere la necessità di una mobilità più sostenibile, e di conseguenza una politica atta al suo sviluppo, dal punto di vista economico, sociale e ambientale, in grado di portare alla luce le necessità del presente, come la salute, e di instradare le generazioni future a fare lo stesso. “Si tratta di una questione fondamentale per la vivibilità del pianeta, sempre più sconvolto dalla voracità della specie umana in continua crescita numerica: da 1,6 miliardi nel 1900, a 2,5 miliardi nel 1950, a 7,7 miliardi nel 2019”, scrive Maggi in un passaggio del testo.
Se lo sviluppo del traffico è stato in un primo luogo stradale, poi certamente sulle grandi percorrenze ha preso il sopravvento l’aereo, negli ultimi trent’anni considerato il maggiore fallimento delle politiche europee sul clima, perché il notevole aumento dei voli ha portato un’espansione delle emissioni.
A fronte di questo scenario, la pandemia mondiale da Covid-19 ha rappresentato così un vero e proprio cambiamento nel settore della mobilità introducendo l’improvviso e anomalo blocco degli spostamenti delle persone e in parte delle merci. Fermando il traffico, permettendo la diminuzione dell’inquinamento, originando un nuovo modello di vita, diverso da quello dell’ipermobilità, sostituendo con l’online la presenza fisica, è cambiata la percezione dei tempi e degli spazi: secondo l’indagine dell’Osservatorio Audimob di Isfort, con il regime di restrizioni, nel periodo tra l’11 marzo e il 10 aprile 2020, gli spostamenti si sono ridotti del 64% e i chilometri percorsi dai cittadini del 90%. I lunghi spostamenti della giornata hanno fatto spazio a percorsi brevi a piedi, tornando a quella “mobilità di prossimità” tipica dei nostri nonni e bisnonni.
Dopo il lockdown, la ripartenza è stata salutata da alcune amministrazioni e da chi è promotore di modelli di mobilità sostenibile come un punto di partenza per ripensare il sistema: meno traffico con lo smart working, il lavoro agile e l’utilizzo dei servizi di prossimità, differenziazione degli ingressi al lavoro, nelle scuole, negli ospedali, permettendo minori affluenze nelle ore di punta e un utilizzo migliore degli spazi e dei servizi (parcheggi, autobus, tram, metropolitane). È quindi necessario che il nostro impatto sull’ambiente sia migliore, perché l’ambiente siamo noi. Ed è forse questo il messaggio sostanziale del libro di Stefano Maggi, muoversi nel XXI secolo in modo intelligente e sano.




